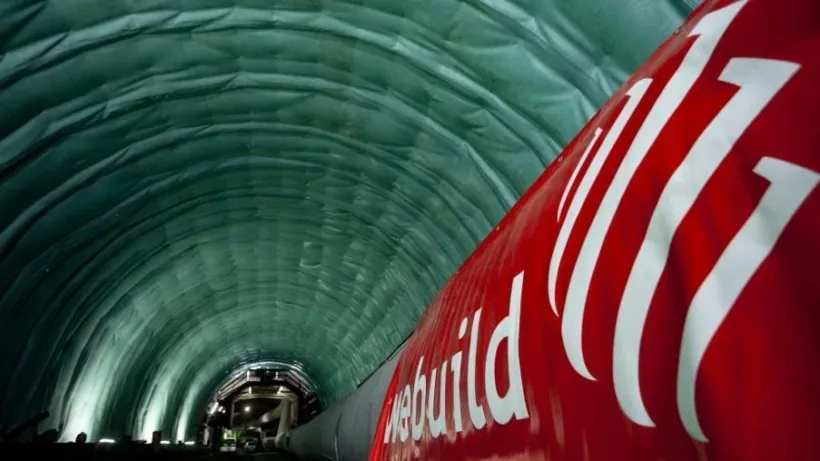Il destino della Tobin Tax a livello europeo e il percorso italiano
Dopo oltre un decennio di dibattiti e tentativi, la Commissione Europea sembra aver definitivamente accantonato l’idea di una Tobin Tax comunitaria. Le varie proposte legislative avanzate nel tempo non hanno mai trovato spazio per essere attuate, considerando anche che alcuni Stati membri, Italia in testa, hanno scelto di adottare autonomamente forme di questa tassazione.
Origini e scopi della Tobin Tax
La Tobin Tax prende il nome dall’economista e premio Nobel James Tobin, che nel 1972 ne ipotizzò l’introduzione per limitare la volatilità eccessiva nei mercati valutari. L’idea, da allora, si è trasformata in un’imposta sulle transazioni finanziarie concepita per scoraggiare la speculazione a brevissimo termine senza colpire gli investimenti a lungo periodo. Pur originariamente pensata per il Forex, oggi questa tassa è stata estesa in diversi Paesi europei anche a strumenti come azioni, obbligazioni e derivati, con l’obiettivo di contenere pratiche finanziarie a rapida rotazione che causano instabilità.
I motivi del fallimento dell’iniziativa europea
La proposta europea di istituzione della Tobin Tax nacque con intensa enfasi nel 2011, nel contesto della crisi del debito sovrano che colpì duramente alcuni Paesi mediterranei. Il piano prevedeva aliquote standardizzate: lo 0,1% su azioni e obbligazioni, e lo 0,01% sui derivati, applicate a transazioni riguardanti istituzioni finanziarie con almeno una delle due parti basata in un paese membro UE. Tale tassazione si fondava sul principio di residenza, col fine di includere anche le operazioni spostate fuori dal continente europeo.
Tuttavia, la proposta ha incontrato opposizioni significative da parte di Stati come Regno Unito, Svezia e Lussemburgo, che hanno evidenziato problematiche strutturali, dal disallineamento dei sistemi fiscali nazionali alla preoccupazione di ridurre la liquidità nei mercati e aumentare i costi del capitale. A ciò si aggiungeva il rischio concreto che le transazioni si spostassero verso giurisdizioni prive di questa imposta, vanificando lo scopo della tassa.
Mikhail Maslennikov di Oxfam Italia sottolinea che la rinuncia a una tassa comunitaria rappresenterebbe un’occasione mancata per rispondere efficacemente alle richieste dei cittadini, utili sia a limitare la speculazione sia a generare risorse da destinare a cause sociali, ambientali e di solidarietà.
Come si è mosso l’Italia
Nel frattempo, alcuni Stati membri hanno deciso di procedere autonomamente. L’Italia, per esempio, ha introdotto nel 2013 una versione propria della Tobin Tax sulle azioni e sui derivati legati a titoli azionari italiani. Le aliquote applicate sono dello 0,1% per le azioni e dello 0,2% per i derivati. Tuttavia, la normativa italiana presenta varie limitazioni:
- La tassa riguarda solo azioni di società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro.
- Il prelievo sulle azioni si applica esclusivamente all’acquisto, non alla vendita short; nel secondo caso, la tassa si calcola al momento del riacquisto.
- Non si tassa il trading intraday sulle azioni, ma solo le operazioni multiday.
- Le società estere o italiane con sede legale fuori dall’Italia non sono soggette alla tassa, così come le transazioni effettuate tramite market maker.
L’entrata annuale stimata da questa imposta è di circa 400 milioni di euro.
Altri esempi europei di Tobin Tax
Prima dell’Italia, nel 2012, la Francia aveva introdotto una tassa sulle transazioni azionarie relative a società nazionali con capitalizzazione superiore a un miliardo di euro, con un’aliquota dello 0,3% sulle operazioni di acquisto. Anche il Belgio ha applicato un’imposta simile su azioni, obbligazioni e derivati, con aliquote variabili dall’0,12% allo 0,35%, mentre l’Austria ha sperimentato regimi analoghi sin dal 2011, modificandoli successivamente. Altri Paesi come Grecia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia hanno adottato forme di imposizione, mentre nazioni come la Germania hanno escluso l’applicazione di una tassa di questo tipo dopo averne discusso.